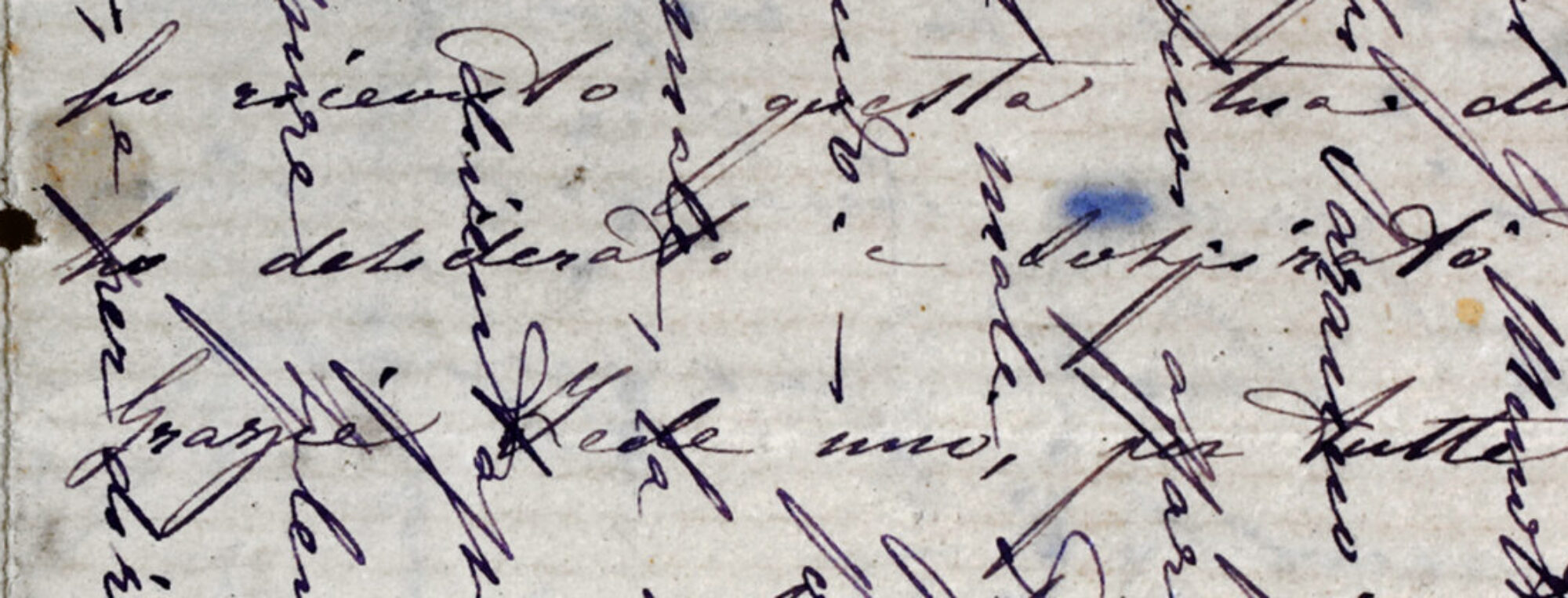Oggi si conclude questo intenso viaggio: abbiamo provato a condurvi nelle quarantene del passato, all’interno delle vite e delle esperienze di chi, prima di noi, si è ritrovato a fronteggiare gravi epidemie, ritrovandosi spesso isolato.
Domani, 18 maggio, per il nostro Paese sarà un giorno importante e simbolico, un giorno in cui l’Italia proverà a ripartire, pur consapevole delle difficoltà che ancora ci attendono. A tutti voi va oggi il nostro abbraccio e il nostro augurio più sincero, affinché tutto possa presto tornare alla normalità, nella speranza che la vita torni a sorriderci.
Forse il miglior augurio che possiamo farvi oggi è proprio questo, che si torni alla nostra quotidianità, alla normalità a cui ci eravamo abituati, alla semplicità delle nostre piccole cose che in queste settimane di isolamento abbiamo imparato a considerare tutt’altro che piccole.
In bocca al lupo a tutti voi. E al nostro Paese.
❝La guerra era ormai finita da un pezzo, ma quando qualcuno di noi andava a domandare se, e quando, le nostre famiglie sarebbero ritornate, tutti si stringevano nelle spalle e nessuno sapeva niente. La gente, sbandata, era giunta al limite della sopportazione. Gli anni erano passati, tragici e lenti, affievolendo o esasperando gli affetti, avevano aperto anche i campi di concentramento e tutti si sforzavano di dare un riassetto alle rovine e di ricomporre i focolari. Radi, laconici, tramite la Croce Rossa, arrivavano i brevi messaggi che inasprivano ancora di più il desiderio di ritrovarsi, ma di noi, dei nostri, non ne parlava nessuno: il governo italiano da una parte e l’amministrazione militare britannica dall’altra, avevano ben altro da pensare. Gli inglesi, se mai, preferivano stancarci per far partire anche gli italiani rimasti, piuttosto che far tornare gli assenti: non ci vedevano di buon occhio, ed era un modo anche quello, come del resto ci aspettavano, di farcela pagare.
Fu allora che i più coraggiosi e i più disperati, fregandosene dei visti e dei permessi, decisero di provvedere per conto proprio ed il Mediterraneo, forse per la prima volta nella storia, vide le barche da pesca trasformarsi in navigli passeggeri. Gusci di noce, carichi per la maggior parte di donne e di bambini, affrontarono alla cieca più di 500 chilometri di mare aperto, in balia delle onde e del vento, dell’angoscia e della sete.
Arrivavano di notte, braccati dalla polizia, e andavano a nascondersi, in generale, negli anfratti della costa alta di Gargaresc da dove, a piedi e per vie traverse, si sparpagliavano verso i poderi e la città.
Qualche barca, dirottata dal vento, andò a finire fino alle scogliere di Corradini; qualcun’altra, inghiottita dal mare, non arrivò mai, ma la perizia e il fegato dei pescatori siciliani prevalsero quasi sempre; io li ho visti scendere a terra barcollanti, sfiniti: urlavano per aver da bere e quando si attaccavano all’acqua bisognava trattenerli perché non scoppiassero. Sui visi le tracce della paura, del sonno e della fame e addosso degli stracci fradici che li facevano rabbrividire. Chiedevano notizie, consigli, volevano sapere quale era la strada più breve e più sicura per arrivare a casa, che cosa sarebbe successo se la polizia li acciuffava. Se la polizia li acciuffava, poiché le barche erano già ripartite e non poteva rimandarli indietro, c’era la quarantena del campo profughi, la trafila nelle caserme e poi la multa che nessuno era in condizioni di pagare.
Ma ormai il peggio era passato, la pelle era salva e non avevano più paura di niente: bastava esser vivi e riavere un uomo, un pane, una casa.
Che triste, eroica, scalcinata ed avventurosa seconda migrazione di tanta nostra gente! Avevano giocato la vita per non rassegnarsi alla sfortuna, ma non tutti ritrovarono un uomo, un tetto, un pane: qualcuno era morto, al posto di certe case c’era una maceria e ci fu anche qualche povera madre che arrivando inaspettata, trovò dentro casa un’altra donna. […]
Sono passati più di sette anni da quel lontano giugno del ’40, quando mi fermai a guardare dal lungomare, profilata nel buio, la sagoma nera del “Liguria” che mi portava via la famiglia.
Un’ora prima, scendendo la scaletta della nave – questa volta da solo – avevo incontrato Balbo che la risaliva: era scuro in volto, ma si sforzava di sorridere, per dare coraggio alle donne e ai bambini, prima dell’incerto viaggio.
Lui, certamente, ormai sapeva il giorno e l’ora dell’inizio della tragedia che poi gli costò la vita, ma noi no; noi sapevamo soltanto che tutti i giorni e tutte le ore erano buone e ci accontentavamo di restare appoggiati al parapetto, in attesa che le navi dell’improvvisato convoglio, sparissero dietro i moli. L’aria della guerra, dalle lontane frontiere, già spirava sul nostro mare e noi ci chiedevamo, ricordo, prima ancora che incominciasse, come e quando sarebbe finita, perché il credere e l’obbedire a tutto quello che ci dicevano, non ci era mai andato giù.
Sette anni! C’è stata una strage, la prigionia, il vuoto, ma ora basta.
Sono qui ad aspettarli, mi hanno scritto che vengono, la prima nave è già in porto, tutti chiamano e chiamiamo anche noi, ma nessuno capisce niente. Però il mare che quella lontana sera sapeva di alghe e di fogna, oggi luccica e odora.
Laggiù, sotto gli alberi, il Campo Maltese; dentro la cancellata la gente in arrivo e noi, ancora lontani, noi uomini, noi babbi, dietro la polizia che ci trattiene.
Noi tratteniamo il respiro. Se ci sono debbono uscire di lì.
Qualcuno si affaccia e gesticola, ma non ricordo più niente. Il cervello mi spaccava le tempie e quando li vidi spinsi, ma una gomitata nello stomaco mi ributtò indietro ed allora mia moglie si mise a correre, trascinandosi dietro le due bambine più piccole. Ma l’ultima, quella che non avevo mai visto, non voleva correre. Per lei, io ero soltanto una parola, ma io l’agguantai, la strinsi, agguantai tutti, strinsi, e nella stretta, non seppi nemmeno più di chi fossero le braccia e le lacrime.❞
l’uscita su Facebook (leggi e commenta)
(dalla memoria di Adriano Andreotti, conservata presso l’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano)
scheda completa
Un giovane padre, perito agrario, decide di partire nel 1932 con la famiglia per la Libia, dove molti italiani hanno impiantato aziende agricole. Nel 1940 le strade si riempiono di soldati, Adriano deve rimandare la famiglia in Italia, viene fatto prigioniero. La guerra, con la sconfitta dell’Italia, porta all’indipendenza dello Stato e alla confisca da parte della Libia dei beni degli italiani che sono costretti al rimpatrio. Rientra amareggiato nel 1959 dopo aver perso tutto, portando con sé solo la nostalgia di questa terra.